Nei giorni scorsi è stato presentato il Rapporto Caritas 2014 sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia dal titolo “False partenze“, che apre una finestra sul fenomeno della povertà in Italia secondo l’esperienza di ascolto, osservazione e animazione svolta dalle 220 Caritas diocesane presenti sul territorio nazionale. Perchè “False partenze”? Il precedente Rapporto, pubblicato nel mese di ottobre 2012, aveva come titolo “I ripartenti”. Si trattava di una finestra aperta su povertà croniche e inedite, ma anche su possibili percorsi di risalita da tali situazioni di sofferenza. Purtroppo, a distanza di un anno e mezzo da tale pubblicazione, la “ri-partenza” non si è mai compiuta. E più che ri-partenze si sono verificate “false partenze”: molte persone, puntando all’emancipazione, hanno accettato di rimettersi in gioco, impegnandosi in attività lavorative non adeguate rispetto alle loro capacità, sopportando situazioni di evidente sfruttamento, sotto-retribuzione, condizioni di lavoro al limite del degrado, ecc.
Il Rapporto analizza ed approfondisce questa situazione, riportando i dati del fenomeno, le principali tendenze di mutamento, i percorsi di presa in carico; i progetti anti-crisi economica delle diocesi, una sintesi di una indagine nazionale sulla condizione di povertà dei genitori separati in Italia, i dati sul “Prestito della Speranza”, e una serie di orientamenti e raccomandazioni in tema di politica sociale e coinvolgimento delle comunità locali. Il Rapporto contiene inoltre un confronto con i dati del secondo rapporto di monitoraggio dell’impatto della crisi economica nei “paesi deboli” dell’Unione Europea, realizzato a cura di Caritas Europa.
Dall’ analisi degli operatori delle Caritas diocesane emerge con chiarezza l’incapacità dell’attuale sistema di welfare di farsi carico delle nuove forme di povertà e delle nuove emergenze sociali conseguenti alla crisi economico-finanziaria e aggravate dalle politiche di austerità e di contenimento della spesa pubblica. A livello complessivo si conferma la presenza di una quota maggioritaria di stranieri (61,8%) rispetto agli italiani (38,2%). La quota di italiani è più forte nel Sud (59,7%). Si tratta in prevalenza di donne (54,4%), di coniugati (50,2), disoccupati (61,3%), con domicilio (81,6%). Hanno figli il 72,1%. Sono separati o divorziati il 15,4%. Il 6,4% è analfabeta o completamente privo di titolo di studio.
Nel corso del 2013, il problema‐bisogno più frequente degli utenti dei CdA Caritas è stato quello della povertà economica (59,2% del totale degli utenti), seguito dai problemi di lavoro (47,3%) e dai problemi abitativi (16,2%). Tra gli italiani l’incidenza della povertà economica è molto più pronunciata rispetto a quanto accade tra gli stranieri (65,4% contro il 55,3%). Più elevata la presenza di problemi occupazionali tra gli immigrati rispetto agli italiani (49,5 contro il 43,8%). Interessante notare come i problemi familiari siano più diffusi tra gli italiani (13,1% rispetto al 5,7% degli stranieri), mentre la situazione appare rovesciata per quanto riguarda i problemi abitativi, più diffusi nella componente straniera dell’utenza (17,2 contro il 14,6%).
Una fetta cospicua di utenti richiede beni e servizi materiali (34,0%). Vi sono poi le persone che richiedono al CdA l’attivazione e il coinvolgimento di soggetti ed enti terzi (26,8%) o che richiedono al CdA orientamento a servizi o informazioni su misure/prestazioni socioassistenziali disponibili nel territorio (10,3%). Un aiuto economico è richiesto in modo esplicito da una minoranza di persone (10,7%). La ridotta entità di tale forma richiesta è riconducibile alla crescente presenza nelle diocesi di altre misure di sostegno economico (micro credito familiare o d’impresa, Prestito della Speranza, fondi diocesani di solidarietà, ecc.).
Evoluzione e sviluppo di nuove forme di povertà
Ad oltre cinque anni dallo scoppio della crisi economica, si evidenziano alcune importanti dinamiche di povertà:
- rispetto al trend di aumento dell’utenza CdA degli ultimi anni, i dati relativi al biennio 2012‐2013 ci segnalano situazioni non sempre uniformi: aumenta la richiesta di aiuto, la fila di persone davanti ai CdA si allunga, ma non tutte le persone in difficoltà sono prese in carico dai CdA. Tale fenomeno è dovuto alla crescente complessità dei casi sociali, che richiedono tempi lunghi di ascolto e colloqui ripetuti nel tempo. Per tale motivo, accanto ad alcune diocesi dove gli utenti Caritas aumentano, ve ne sono altre dove tale numero appare in diminuzione;
- è confermata la crescente presenza degli italiani, che in alcuni casi raggiungono e superano la maggioranza assoluta delle presenze nei Centri di Ascolto;
- ceto medio e gruppi sociali tradizionalmente estranei al disagio sociale sono sempre più coinvolti dalla vulnerabilità economica;
- non tutte le persone e le famiglie in difficoltà economica si rivolgono alla Caritas o ad altri enti simili;
- ceto medio e nuove povertà familiari si rivolgono o sono agganciate da servizi spesso innovativi, non sempre coincidenti con le tradizionali strutture di aiuto;
- sempre meno utenti Caritas sono presi in carico congiuntamente dai servizi sociali o da altri enti socio‐assistenziali.
La povertà e il disagio dei genitori separati
Nel Rapporto è riportata una sintesi dei principali risultati della prima indagine nazionale sulla condizione di vita dei genitori separati, finalizzata a far emergere soprattutto il legame tra rottura del rapporto coniugale ed alcune forme di povertà/disagio socio‐relazionale. La rilevazione ha coinvolto la rete Caritas e quella dei Consultori familiari d’ispirazione cristiana (afferenti alla CFC, Confederazione Italiana Consultori Familiari d’ispirazione cristiana). Sono state realizzate 466 interviste a genitori separati, presso centri di ascolto (36,9%), consultori familiari (33,5%), servizi di accoglienza (18,5%) e mense (8,2%). Dai dati empirici si evidenzia:
- un forte disagio occupazionale degli intervistati: il 46,1% è infatti in cerca di un’occupazione;
- dopo la separazione: diminuisce notevolmente la percentuale di coloro che vivono in abitazioni di proprietà o in affitto. Al contrario aumentano vistosamente le situazioni di precarietà abitativa: cresce il numero di persone che vivono in coabitazione con familiari ed amici (dal 4,8% al 19,0%), che ricorrono a strutture di accoglienza o dormitori (dall’1,5% al 18,3%), che vivono in alloggi impropri (dallo 0,7% all’5,2%);
- il 66,1% degli intervistati dichiara di non riuscire a provvedere all’acquisto di beni di prima necessità (prima della separazione tale percentuale riguardava solo il 23,7% degli intervistati); tra gli utenti Caritas tale percentuale sale all’81,7%;
- dopo la separazione aumenta il ricorso ai servizi socio‐assistenziali del territorio: centri di distribuzione beni primari (49,3%), mense (28,8%) e gli empori/magazzini solidali (12,9%).
- dopo la separazione si evidenzia un aumento dei disturbi psicosomatici: il 66,7% degli intervistati accusa infatti un numero più alto di sintomi rispetto al pre‐separazione;
- la separazione incide negativamente nel rapporto padri‐figli; il 68% dei padri intervistati riconosce un cambiamento importante a seguito della separazione (a fronte di un cambiamento percepito solo dal 46,3% delle donne); tra i padri che riconoscono un cambiamento il 58,1% denuncia un peggioramento nella qualità dei rapporti (le madri al contrario riconoscono per lo più un miglioramento).
Povertà nazionale, tendenze europee
Il rapporto contiene una sintesi dei dati provenienti dal secondo rapporto di monitoraggio dell’impatto della crisi economica in sette “paesi deboli” dell’Unione Europea (Italia, Portogallo, Spagna, Grecia, Irlanda, Romania, Cipro), curato da Caritas Europa, e presentato il 27 marzo 2014 ad Atene, in occasione del semestre di presidenza greco dell’Unione Europea.
Nel testo sono riportati dati e testimonianze relative all’impatto della crisi sui paesi deboli dell’Unione Europea, le forme di intervento delle Caritas nei paesi caso‐studio e una serie di alutazioni e raccomandazioni rivolte alle istituzioni europee.
Alla fine del 2012 la disoccupazione appariva significativa in tutti i paesi caso‐studio del Rapporto, con particolare riguardo alla situazione della Spagna, dove quasi 6 milioni di spagnoli, uno spagnolo su quattro in età attiva, sono privi di lavoro. La Grecia si colloca al secondo posto per incidenza dei disoccupati (24,3%), seguita dal Portogallo (15,9%). In questa poco lusinghiera classifica, l’Italia si colloca al sesto posto in termini relativi (10,7% di disoccupati), ma al secondo in posto in valori assoluti (2 milioni 744mila di persone disoccupate). La Grecia è il paese dove si manifesta con maggiore evidenza la disoccupazione giovanile (55,3%), mentre la disoccupazione di lunga durata è più forte in Irlanda (61,7%). In Italia, la disoccupazione generale si allinea sostanzialmente sui valori medi europei, mentre quella giovanile appare più grave (35,3% della forza lavoro 15‐24 anni).
Secondo i dati Eurostat, alla fine del 2012 il 25% della popolazione europea (124,4 milioni di persone, un quarto del totale) era a rischio di povertà o esclusione sociale; 4 milioni in più rispetto al 2011. Negli stati membri l’infanzia rappresenta il gruppo sociale a maggiore rischio di povertà: nel 2012 il 27,0% dei minorenni europei era a rischio di povertà ed esclusione sociale, rispetto al 24,3% degli adulti (tra i 18 e i 64 anni d’età) e al 20,5% degli anziani (con più di 65 anni). Un bambino su cinque nell’UE è a rischio di povertà.
Le Caritas dei paesi deboli evidenziano alcune tendenze comuni di impoverimento, che appaiono più significative soprattutto per quanto riguarda i paesi storici dell’Unione Europea (Spagna, Portogallo e Italia). In Portogallo aumentano le famiglie assistite dalla Caritas del 107%; in Spagna aumentano del 77,7% le persone assistite (da 1.015.276 a 1.804.126). Emergono dalla crisi nuove forme di povertà e nuove domande sociali, che interpellano le comunità locali e richiedono l’attivazione di rinnovate forme di intervento da parte delle Caritas. Non manca in nessuno dei paesi coinvolti l’erogazione di aiuto materiale, più evidente ed esclusivo nel caso di Cipro, Romania e Grecia, mentre nelle Caritas di più antica istituzione (Spagna, Italia, Portogallo), l’azione di solidarietà materiale si accompagna ad attività di animazione pastorale, accompagnamento formativo, di studio e ricerca, di lobby e advocacy nei confronti delle istituzioni pubbliche.
Il Prestito della Speranza: Il Prestito della Speranza, nato dall’accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana e l’Associazione Bancaria Italiana, è un’iniziativa orientata a favorire prestiti agevolati, garantiti da un Fondo specificatamente costituito dalla CEI. L’obiettivo è quello di dare un segno di speranza a quanti oggi si confrontano con gli effetti più immediati della crisi e, nel contempo, educare all’uso responsabile del denaro e al dovere della restituzione, una volta superata la situazione di indigenza. I potenziali destinatari sono tutte le famiglie che versano in situazioni di disagio o di indigenza e/ le microimprese da esse promosse. Dal 2009 ad oggi 3.583 sono le famiglie sostenute, per un totale di oltre 22 milioni di euro di finanziamenti erogati.
Prospettive e proposte per il welfare e le politiche pubbliche: Un’ultima parte del Rapporto si sofferma sulle tendenze degli attuali assetti di welfare, evidenziando nodi critici e possibili proposte di miglioramento. Appare positivo, ad esempio, il rifinanziamento del Fondo nazionale per l’autosufficienza, così come l’introduzione del nuovo Isee, il rinnovato “termometro” nazionale necessario per determinare i livelli di accesso a varie tipologie di prestazioni sociali e assistenziali. Tuttavia, la reale operatività di entrambi i provvedimenti non sarà immediata. Troppo spesso, la ratifica legislativa di molte misure non coincide con la loro immediata operatività, determinando incertezza e criticità a processi pur virtuosi di riforma. Incertezze e preoccupazioni si riferiscono al futuro degli aiuti alimentari nel nostro paese.
Come noto, il 31 dicembre 2013 ha chiuso i battenti il PEAD, il vecchio Programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti dell’Unione Europea, sostituito da un nuovo fondo, il FEAD, che non rientra più nelle politiche agrarie dell’UE, ma in quelle inerenti il welfare. L’avvio del nuovo programma nei singoli paesi sarà condizionato al completamento di un percorso su base nazionale, che prevede la definizione di un Piano nazionale, condiviso con i soggetti coinvolti (Regioni ed enti caritativi); l’approvazione in sede europea del Piano; la definizione da parte dell’Amministrazione (Ministero del Lavoro e Politiche sociali) di un Bando per l’accesso dei soggetti erogatori. L’intero iter dovrà essere poi autorizzato e avallato dall’Unione Europea. I tempi effettivi dell’intera operazione sono tutti da verificare, ma sono tali da non rassicurare circa il rischio di una eventuale temporanea sospensione del programma.
Aspetti di criticità sono infine ravvisabili nel carattere sperimentale e provvisorio di molte delle recenti novità legislative. Da un lato, se è oggettivo riconoscere che la legge di stabilità 2014 ha impegnato un ammontare di risorse mai visto in questi ultimi anni per la lotta alla povertà, dall’altro lato assistiamo a percorsi di implementazione definiti ancora una volta nei termini di “sperimentazione” (si pensi alla nuova Carta Acquisti), senza una prospettiva normativa definita e di copertura economica chiara di eventuali ulteriori misure in questo ambito. Il rischio è quello di avviare grandi cantieri territoriali che non trovano esito legislativo, generando più un sentimento di amarezza nei confronti di un’opera incompiuta, che la sedimentazione di competenze e strumenti efficaci di contrasto alla povertà.
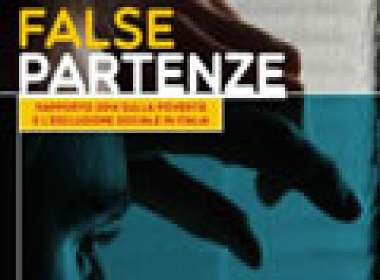

Potrebbe interessarti:
- Il Consiglio d’Europa nel suo rapporto sulle violazioni della Carta sociale europea: “in Italia troppo basse le pensioni minime”
- Le Considerazioni generali del 47° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese 2013
- Terzo Rapporto sulla coesione sociale
- 46° Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2012
